
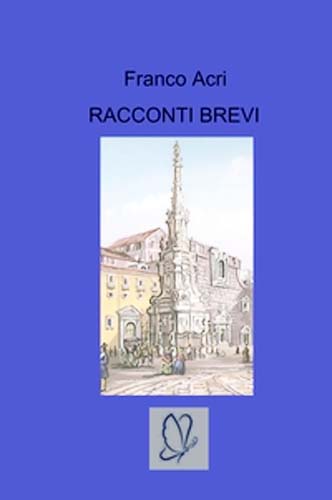
Racconti brevi
Franco Acri – Architetto per vocazione, poeta per necessità
La mia storia inizia in Calabria e mette radici a Napoli, città che mi ha accolto per gli studi e che ho imparato ad amare. L'Istituto d'Arte, prima, e poi l'Università, mi hanno insegnato a dare forma alla materia. Ma presto ho capito che c'è una materia ancora più urgente da plasmare: il pensiero. Scrivo per non dimenticare, per lasciare tracce, per ricucire i fili dispersi dell'esistenza. Ogni poesia nasce da un gesto, un incontro, una crepa nel tempo. Credo in una memoria che non si affida ai libri, ma si deposita nelle pieghe dell'anima: nel pane impastato ogni giorno, nello sguardo rivolto a un albero caro, nel silenzio che abita una stanza ormai vuota. Architettura e scrittura non sono mondi separati, ma due facce dello stesso impegno: costruire. Se l'architettura modella lo spazio, la poesia mi consente di denunciare le contraddizioni, di esplorare ciò che non trova posto nelle geometrie. La professione mi ha insegnato a progettare luoghi; la scrittura, invece, mi affida un compito più intimo: custodire il tempo. Architettura e poesia sono, per me, due modi complementari di dare forma al mondo: l'una vincolata dalle leggi della materia, l'altra libera di attraversare le verità interiori. In questo spazio – il blog – mi concedo la libertà dell'esplorazione: parole che resistono, e silenzi che sanno ancora dire.Inserisci qui il tuo testo.
Ritorni e Memorie: Racconti di Franco Acri
Prefazione
Tornare non è mai un gesto neutro. È un atto che scava, come la lama di una matita che affila il legno per ritrovare la punta. Ogni ritorno contiene la vertigine del riconoscere e del non riconoscere. Ritorni e Memorie nasce da questa vertigine.
Questo libro nasce dal desiderio di fermare il tempo, di catturare la memoria dei luoghi, delle persone e degli attimi che ci definiscono. Le pagine che seguono sono un intreccio di storie personali, incontri casuali e ritorni nei luoghi dell'infanzia e dell'anima.
Un architetto, per mestiere, disegna spazi per la vita futura. Ma c'è un luogo che non si progetta: il passato. Questa raccolta è il mio tentativo di disegnare quel tempo, di non lasciare che i ricordi scivolino via come intonaco dalle pareti di una casa abbandonata.
Alcuni racconti si svolgono a Luzzi, il mio paese natale, dove le pietre, i vicoli e le persone hanno plasmato la mia identità. Altri racconti, invece, si ambientano nei luoghi delle mie vacanze o nel paese dove vivo oggi, come Concetta, sulla riva e Sotto l'acacia. Questi spazi, pur non essendo Luzzi, sono intimamente legati al mio passato: evocano ricordi della mia giovinezza, dei giochi e delle amicizie, dei momenti che mi hanno formato.
I racconti sono anche un manifesto: criticano il grigio anonimo che ha deturpato i nostri paesaggi, la deriva di una professione che ho amato, il rammarico per aver "riqualificato le pietre" senza salvare le persone.
Ogni racconto è un piccolo viaggio: verso i paesaggi reali o simbolici che hanno plasmato la mia vita, verso le amicizie che resistono al tempo, verso le radici che non si perdono mai del tutto. Tra Luzzi, le spiagge, i bar di quartiere e i vicoli dell'infanzia, le parole diventano un filo che collega passato e presente, memoria e consapevolezza.
Questo libro non racconta la Storia, ma le storie. Quelle intime, spesso silenziose, che fanno respirare la vita vera.
Franco Acri
Indice
Fine luglio, in auto verso Luzzi
Il Passato che ritorna
Sotto l'acacia
Concetta, sulla riva
C'era l'Architettura
Domenica
Dove avevamo lasciato tutto

Fine luglio, in auto verso Luzzi
Era parecchio tempo che non tornavo a Luzzi. Il benvenuto mi è stato dato dal termometro dell'auto: quaranta gradi centigradi.
La Valle del Crati, un luogo arroventato! Una fossa tettonica, delimitata a ponente dalla Catena Costiera e a levante dall'altopiano della Sila. Un luogo poco influenzato dalle correnti marine, con un microclima dettato dalla sua particolare orografia.
Ed eccolo, il paese! Adagiato sulla prima piega dell'altopiano.
Questa strada che corre tra il fiume Crati e la ferrovia offre viste particolari di Luzzi man mano che la percorri. Da questa strada provinciale, più nota come "strada della bonifica", si può scorgere gran parte del territorio luzzese. Dalla valle alla montagna, e nel mezzo il "centro storico", delimitato dai due torrenti: Ilice e San Francesco.
Sulla sponda destra del torrente San Francesco, la nuova espansione del paese, dove c'è di tutto: dalle case popolari alle scuole, all'urbanizzazione selvaggia.
La parte più bassa, che si estende dal fiume Crati alle nude colline argillose, un tempo caratterizzate dai rizomi di liquirizia, è quella che ha subito le maggiori trasformazioni negli anni. Oggi queste colline appaiono deturpate da costruzioni a basso costo con intonaci colorati, sparse senza nessuna logica urbanistica, come le parole di una poesia "dadaista". Un'architettura che ci riporta direttamente al dopoguerra o peggio, all'abusivismo.
Non avevo mai pensato che su quelle colline instabili, dove i torrenti confluiscono in un unico corso d'acqua per poi unirsi al fiume Crati, si potesse creare un grande quartiere dormitorio. Davvero, non c'è limite al peggio.
Invece, la parte montana, vista da qui, sembra non aver subito grandi trasformazioni nel corso degli anni. Questo è senza dubbio dovuto allo spopolamento, alla migrazione interna.
Mentre rifletto su tutto ciò e sulle notevoli trasformazioni che i paesi collinari e montani calabresi hanno subito – paesi che, a differenza dei piccoli centri costieri, non possono fare affidamento sul turismo estivo – mi ritrovo sul ponte del torrente Annea. Così, inavvertitamente, mi giro a guardare di nuovo il paese. Oltre all'abitato, da questa prospettiva è ben visibile il cimitero, che è l'unica cosa in continua espansione. Naturalmente senza alcun criterio, come vuole la tradizione, mentre il resto svanisce giorno dopo giorno.
A questo punto è doveroso aprire una parentesi sulla parte "storica" del paese, che è in uno stato di totale abbandono. Quella tra i due torrenti, quella delle chiese, quella dove sono nato. Sì, sono nato e cresciuto in uno dei primi insediamenti medievali del paese.
Un dedalo di strette viuzze concentriche, disegnate, modellate e talvolta scavate nella roccia cristallina, incastonate tra le case che si arrampicano sopra i tetti verso la zona più alta. Dove un tempo c'era il castello con le sue porte. (Oggi è rimasta solo la toponomastica).
Ci sono tanti ricordi in quei vicoli, che si intersecano e si perdono in slarghi: delimitati da case con ballatoi sagomati e non costruiti. (Chi come me ha vissuto nella parte "storica" sa bene che Luzzi non è stato costruito, ma è stato modellato in quei conglomerati pliocenici di colore bruno-rossastro).
Le case in cui affiora la roccia spesso sono prive di mura. Le grotte e le cavità, che un tempo fungevano da cantine, sono comuni. Sono rare le case isolate, tutte presentano almeno un lato seminterrato. Case e vie sono un tutt'uno, spesso offrendo scorci segreti, di supportici che si aprono su improvvisi squarci di cielo. Frammenti di una vita passata che rimandano a un paese lontano nel tempo.
Ho sempre pensato che, paradossalmente, il vero declino del paese sia iniziato con i lavori di riqualificazione del centro storico. In quegli anni si è commesso l'errore di "riqualificare le pietre", ovvero sostituire l'acciottolato con pavimentazione in porfido e modernizzare servizi e arredo urbano, senza considerare la vita sociale.
Un'operazione che non ha portato vantaggi nel contrastare lo spopolamento. I centri storici hanno bisogno di essere abitati per sopravvivere, non solo visitati o vissuti episodicamente, con eventi culturali o folkloristici.
Oggi il mio quartiere ha raggiunto quasi la "desertificazione", con la chiusura della casa natìa.
Mia madre, che ha quasi novant'anni, è stata costretta a lasciare i vicoli dove è nata, a causa di un'ischemia e del conseguente disservizio sanitario calabrese.
Eppure, le ragioni di questo abbandono sono state banali, se riflettiamo: il traffico automobilistico e i problemi di accessibilità; lo spostamento dell'asse commerciale verso la periferia, che sembrava più accessibile alle nuove esigenze economiche e sociali.
Se penso alla mia infanzia rispetto a quella delle generazioni future, mi ritengo fortunato. Oggi è difficile spiegare cosa significhi vivere in quel contesto, in mezzo a quella folla di persone dove si respirava vicinanza. Ogni quartiere era una comunità, tutti condividevano tutto. Quello che sono diventato lo devo probabilmente a quelle persone.
Spiegare a mia figlia che la nonna custodiva le chiavi delle case di tutto il quartiere e ne aveva dato copie delle sue alle zie Mafalda ed Erminia, mi è costato una serata intera e non so se ha capito il motivo.
Che tristezza quando una di quelle porte, di una persona anziana che viveva da sola, restava chiusa oltre una certa ora e si doveva intervenire con le chiavi che mia madre custodiva.
Era naturale vestire i defunti e disporli sul letto. Tutti conoscevano il rituale, sapevano dove erano gli abiti e gli oggetti da mettere nella bara.
Lo slargo davanti casa era il luogo dei giochi, ma anche il salotto di tutti. Si trascorreva poco tempo all'interno delle case, soprattutto perché le stanze erano poche e piccole e c'erano tanti bambini. Mi ritenevo sfortunato perché avevo solo una sorella; i miei amici avevano almeno un fratello oltre alle loro sorelle.
La cosa più preziosa che porto nel cuore è che ognuno di noi si sentiva figlio non solo dei propri genitori, ma di tutto il quartiere. Questo ha aiutato molto chi aveva perso la madre in giovane età. Tutti ti facevano sentire a casa, l'affetto era palpabile.
Capisco che spiegare tutte le sfumature è impossibile, devi averle vissute per coglierne l'essenza.
È difficile spiegare – se non l'hai vissuto – che leggere "Il vecchio e il mare" seduto all'ombra di uno scomodo ballatoio che si affaccia su uno spazio aperto con una fontana, può essere un valore aggiunto alla narrazione. I personaggi del libro si mescolano con le persone reali. Il tuo Santiago è lì di fronte a te e la fontana è un oceano. I romanzi che ho letto in quel contesto così vivace sono quelli che ricordo di più.
Ancora oggi, nelle profondità della mente, rivive la mia "Fortezza Bastiani", il mio "Metello".
Questa stessa magia si risveglia quando incontro gli amici d'infanzia, che come me non vivono più in quei vicoli. Penso che in noi ci sia un'empatia atavica che ci contraddistingue, una complicità e una sintonia che fa sì che pochi gesti o sguardi dicano tutto, gli occhi diventano umidi in quelle occasioni e io torno a essere Franco di Lina.
Forse è la nostalgia, la vera ragione che mi spinge a ritornare regolarmente nel mio paese natìo. Dove, ormai, le uniche certezze consistono nella chiusura delle ultime attività commerciali rimaste – dico commerciali perché quelle artigianali sono svanite tempo fa. Un semplice bar è diventato un privilegio. Per non parlare dell'edicola.
Tutto questo è solo la conseguenza di un circolo vizioso già sperimentato: i servizi diminuiscono, le scuole chiudono, addio ai trasporti. Il resto è facile immaginarlo.
Non ho ancora attraversato il ponte sul Crati, che segna l'ingresso nel territorio luzzese, e ho già un'idea chiara della situazione che mi aspetta. Mancava solo un semaforo prima del ponte a completare l'opera.
I lavori sul ponte Crati, nel corso degli anni, sono stati tanto prolungati quanto la Fabbrica di San Pietro.
Ne approfitto per telefonare a Tonino e avvisarlo del mio arrivo. Sentire la sua voce e in sottofondo il dialogo di Gianfranco e Domenico mi solleva il morale.
Il semaforo diventa verde proprio al termine della telefonata.
Nella ripartenza ho trovato la risposta al perché torno volentieri a Luzzi, anche sotto il solleone. Questa volta a suggerirmelo è stato il contagiri del motore dell'auto.
Il Passato che ritorna
Era da un bel po' che non tornavo a Luzzi, il mio paese natale. Non vedevo mia madre da molto, a causa della malattia pandemica e non solo.
Durante i pochi giorni trascorsi in paese, oltre a mia madre e ai familiari, ho avuto modo di ritrovare i vecchi amici. Questa volta, più che gli amici, mi ha fatto piacere rivedere il mio figlioccio, Francesco, il figlio di Gianfranco e Ilaria.
Ci siamo incontrati per caso. Stavo parlando con Gianfranco e Tonino quando è apparso con un cucciolo al guinzaglio e una signorina che non passa inosservata.
Oltre al suo affascinante sorriso, Francesco è diventato un giovane uomo. La sua sempre presente timidezza lo rende ancora più intrigante. La timidezza è un valore aggiunto, una virtù che ti fa comprendere a fondo le situazioni e la psicologia umana. Senza giri di parole, il mio figlioccio è davvero un bel ragazzo e ne sono molto orgoglioso.
Il nostro incontro è stato breve, come sempre, fatto di sguardi e poche parole: ci siamo salutati rapidamente. Purtroppo, il cucciolo è rimasto con noi, ma non la signorina. La serata è proseguita in pizzeria con Tonino e il coprifuoco ha fatto il resto.
Tornando a casa, per i vicoli dell'infanzia, ho ripensato alla mia adolescenza e all'amicizia con Gianfranco. Ci siamo conosciuti quando avevamo l'età di Francesco; entrambi frequentavamo l'Istituto d'Arte.
Per varie vicissitudini, che non sto qui a raccontare, ci siamo ritrovati nella stessa classe, la terza B. Presto siamo diventati compagni di banco e lo siamo rimasti fino al diploma di maturità. Fin dall'inizio ho capito di aver incontrato una persona speciale. In pochissimo tempo si è integrato perfettamente nel gruppo di amici che conoscevo fin da bambino.
Non è mai stato solo l'amico di Franco. Sì, mi chiamo Franco, ma sono conosciuto come Farfallone o Farfalla, come Gianfranco è noto come Corvo. Lui, Gianfranco, è stato sin da subito l'anima del gruppo.
Ormai sono passati più di quarant'anni da quando ci conosciamo e non c'è stata una settimana in cui non ci siamo sentiti. Dico "sentiti" perché da molti anni vivo altrove.
Mentre camminavo lungo il percorso verso casa, cercavo di rievocare gli anni più intensi trascorsi insieme, ma ho avuto difficoltà a stilare una graduatoria. Allora ho pensato che con Gianfranco non c'è un prima e un dopo. Paradossalmente, se fossi una strada, lui sarebbe la segnaletica.
Il silenzio dei vicoli e il rumore dei miei passi mi riportano indietro nel tempo, quando il quartiere era vivo e di notte si sentiva l'odore del pane. In quel silenzio, quasi fastidioso, cerco episodi particolari vissuti durante quegli anni da adolescente. Appena ne penso uno, sembra insignificante rispetto al prossimo che mi viene in mente.
Così si apre un ventaglio di ricordi che va dalla scuola al campeggio, al calcio…
In particolare, mi viene in mente un episodio a cui sono molto legato.
Era estate, Leonardo ed io eravamo nel piccolo spiazzo di via San Francesco. Leo aveva parcheggiato il motorino tra le aiuole che separavano il piccolo parcheggio dalla strada. Piuttosto che seduti, eravamo sdraiati sul muretto, spalla a spalla, aspettando Tonino. Oggi quello spiazzo è cambiato e il muretto non c'è più.
In modo totalmente inaspettato, siamo stati sorpresi da una busta piena d'acqua. Gli autori di quel memorabile scherzo erano Gianfranco e Totonno.
Da quel momento è iniziata una battaglia rocambolesca, nel senso che dopo aver lanciato tanta acqua, gli unici bagnati eravamo io e Leonardo. La battaglia si è conclusa quando una busta piena d'acqua, che è finita addosso a Gianfranco, non solo non si è aperta, ma cadendo a terra ci ha bagnati. A quel punto abbiamo detto "basta!".
Questo ricordo, che per molti potrebbe sembrare banale, è fondamentale per me perché è legato a Leonardo, che ci ha lasciato qualche anno fa. Pensare a Leo da ragazzo mi rende felice.
Con lui non ci siamo conosciuti a scuola, né siamo stati compagni di classe, ma abbiamo vissuto nello stesso quartiere. Per vederci bastava affacciarsi al balcone.
Leonardo, il matematico. Le equazioni non avevano segreti per lui, con una Marlboro tra le labbra sembrava poter risolvere qualsiasi problema.
Leonardo, di cui ogni angolo di questo quartiere mi parla.
Leonardo, che non ho mai battuto allo "strummolo".
Leonardo, che anche questa sera mi ha accompagnato a casa lungo questi vicoli silenziosi.
Leonardo, che non ho mai chiuso la porta di casa senza alzare lo sguardo verso il suo balcone.
Appena entrato in casa, mi sono assicurato che mia madre stesse bene. Dormiva come una bambina, con quel solito sorriso che il tempo non è riuscito a cancellare.
Prima di andare a letto, ho osservato con affetto gli oggetti, i quadri e tutto il resto, che non solo sono rimasti sempre gli stessi, ma conservano fedelmente la stessa posizione.
Prima di addormentarmi, ho notato le mie iniziali sulla federa del cuscino, come se fossero state ricamate il giorno prima. Mi ha fatto riflettere: sto invecchiando, osservando sempre le stesse cose.
In particolare, davanti a un mio omaggio a Giorgio Morandi, dipinto durante gli anni scolastici, ho compreso l'amore e la stima che nutro per il Maestro.
Mia madre, che ignora completamente la pittura di Morandi, condivide con il Maestro l'idea che gli oggetti comuni abbiano una vita segreta.
Questa visione unica e universale delle cose ha creato un linguaggio artistico che è diventato parte integrante della pittura. È difficile per me immaginare la pittura senza pensare alle nature morte di Morandi.
L'associazione tra mia madre e il grande Maestro mi mette di buon umore. Così, con gli occhi sorridenti, ripenso alla scena del gavettone e della busta che non si è aperta, ma soprattutto alla spensieratezza di quei giorni e di quella giovane età.
Ho spento la luce e, con la testa appoggiata sul cuscino personalizzato, ho continuato a sognare.
Sotto l'acacia
A pochi passi da casa, il Bar Roma sembra più un porto per nostalgici che un locale. Roberto, il proprietario, è quasi mio coetaneo: nei suoi occhi, dietro le rughe sottili e il sorriso di chi ne ha viste tante, si riflettono gli anni Ottanta, una gioventù fatta di Vespe rombanti, poster di top model e cinema italiano che sapeva ridere di sé stesso. Nomi come Troisi, Benigni, Verdone, Nuti sono ancora sulle sue labbra, come vecchi amici che tornano a trovarlo ogni tanto.
Fuori, due ombrelloni sbilenchi e sferzati dal vento si contendono lo spazio con un vecchio albero di acacia, la cui ombra è l'unica vera salvezza nelle giornate torride. Prima dell'ingresso, una tettoia di legno e plastica, in parte trasparente, opprime più che accogliere: il tempo l'ha resa pesante e malinconica, come se avesse assorbito tutti i discorsi e i sospiri dei clienti di passaggio.
Dentro, il buio è quasi un'abitudine. Il bancone corre in lunghezza come una pista di atterraggio per tazzine di caffè, mentre una piccola saletta, dominata da una TV sempre accesa, sembra più una tana che un salotto. L'odore stagnante del legno cerato e del fumo vecchio impregna ogni cosa. Il perlinato, che riveste soffitto e pareti fino a una certa altezza, contribuisce a creare un'atmosfera chiusa, quasi claustrofobica.
Eppure, c'è sempre qualcuno. Il vero bar è fuori, tra chiacchiere veloci e sguardi pigri ai passanti, almeno nei mesi caldi dell'anno. Lì si vive, lì si respira.
Li riconosci subito, i cacciatori del Bar Roma. Non serve vedere i fucili, che restano a casa; bastano i loro cappellini mimetici e i giubbotti con tasche troppo grandi. Si siedono sempre allo stesso modo, sulle due panchine di legno scolorito che arredano il piccolo slargo davanti al locale. Non c'è confine tra le sedie del bar e quelle panchine: il marciapiede stesso sembra un prolungamento naturale del locale. Ci si siede dove capita: clienti abituali, passanti curiosi, anziani che non ordinano nulla ma restano a guardare il mondo.
È uno spazio senza regole, dove le conversazioni attraversano i tavolini e si posano sulle ginocchia di chiunque ascolti. Può capitare che uno dei cacciatori racconti una storia a chi sta sulla panchina, o che un vecchio amico si avvicini al bancone solo per salutare, per poi tornare a sedersi fuori.
All'ombra storta dell'acacia e sotto gli ombrelloni tremanti, tutto diventa comunità: nessuno chiede permesso, nessuno è estraneo. Seduto lì, con il caffè che si raffredda troppo in fretta, osservo questo piccolo teatro di vite intrecciate. Il Bar Roma è un bar solo di nome: in realtà è una piazza, un ricordo, un punto fermo. I loro discorsi ondeggiano tra verità e fantasia, tra una beccaccia che non si trova più e un tordo che nessuno ricorda di aver visto davvero.
Il porto d'armi è diventato una tassa salata per coltivare una passione che sembra appartenere a un'altra epoca, ma loro non se ne lamentano troppo; preferiscono raccontare di quell'alba in cui il bosco odorava di terra bagnata, o di quando il cane aveva fiutato qualcosa che non c'era, giurando di aver sentito il frullo invisibile di un volatile pregiato.
Per anni, li ho ascoltati in silenzio. Non per paura, non per disinteresse, ma per rispetto. La loro voce era musica che parlava di radici, di un mondo che avevo conosciuto solo da bambino, nel mio paese natìo. Restavo lì, sorseggiando il mio caffè, lasciando che le loro storie si intrecciassero con le mie, che scivolassero dentro di me come la luce fioca che attraversava gli ombrelloni sfilacciati.
Col tempo ho imparato a conoscerli. So i loro nomi, il mestiere che fanno o che hanno fatto, persino il loro modo di pensare, di affrontare i problemi quotidiani. Li ho visti passare dal vecchio telefonino allo smartphone e, in questo lento cambiamento, ho trovato anch'io il mio spazio nei loro discorsi, nelle loro preoccupazioni.
All'inizio credevo che fermarmi al Bar Roma fosse solo un segno di pigrizia. Mi sbagliavo, come quasi sempre. Quelle persone — artigiani, muratori, operai, migranti — sono finestre aperte sulla vita. Nei loro racconti vedo scorrere sacrifici silenziosi, giornate di fatica, famiglie tirate avanti con dignità. Vedo amicizie lunghe una vita, empatia naturale, amore per la semplicità. Così, da un bel po', ho smesso di ascoltare le loro storie come fosse un passatempo. Oggi quelle storie le vivo: ne sono parte.
Spesso, al ritorno dallo studio, provo una grande nostalgia nel vederli seduti lì, e immagino i loro discorsi. Così parcheggio l'auto e vado a sedermi anch'io tra loro. Basta poco per scordarmi dell'architettura, dei cantieri, dei problemi che oggi affliggono un architetto.
Prima ancora che io prenda posto, qualcuno ha già ordinato per me una birra ghiacciata. Nel sorseggiare quel boccale, tra quelle chiacchiere, tutto sembra scorrere più lentamente, in modo più umano.
A San Clemente ci sono tanti bar moderni: luminosi, con musica in sottofondo e ragazze che ti servono al tavolo. A volte mi capita di trovarmi lì con degli amici, di consumare un aperitivo o un buon calice di vino dei produttori locali. Eppure non è la stessa cosa. I tavoli sono occupati, ma è come se fossero vuoti: i discorsi sembrano preconfezionati, pieni di attenzione e di una furbizia che stanca. Le persone mi appaiono finte, come se quel sedersi al tavolo fosse un modo per dimostrare qualcosa a sé stessi o agli altri: esserci, apparire presenti. Così è per la colazione come per l'aperitivo.
In quei momenti non vedo l'ora di tornare sotto l'acacia, di uscire dal brusio e ritrovare le storie vere, gli errori, la vita.
Alla fine, il Bar Roma non è un luogo: è un tempo sospeso. Lì i discorsi non hanno fretta, i sorrisi non hanno secondi fini. Le rughe dei clienti raccontano storie più sincere di qualsiasi notizia al telegiornale.
Io resto seduto sotto l'acacia, con il boccale mezzo vuoto e il vento leggero che fa tremare gli ombrelloni stanchi. Roberto, dietro il bancone, saluta un cliente chiamandolo per nome; i cacciatori discutono se la stagione sarà buona; il barbiere ride di una battuta che ormai conosciamo tutti a memoria.
Ed è proprio in questa semplicità che sento la vita pulsare: non nelle luci brillanti dei locali alla moda, né nei brindisi studiati a memoria, ma qui, in questo piccolo slargo senza confini, dove le storie diventano una sola e anch'io mi scopro parte di esse.
Sotto l'acacia, il tempo sembra smettere di correre. E forse, per un attimo, il mondo intero respira più piano.
Concetta, sulla riva
Stasera, sulla spiaggia, si è aperto un lungo dialogo con una signora anziana di nome Concetta. C'era qualcosa di familiare nei suoi modi garbati, nelle movenze gentili, nella sua voce. Vive a Brescia da oltre sessant'anni, eppure, mentre parlava, si avvertiva un altrove, un'origine rimasta viva dentro di lei.
Con discrezione, le ho chiesto delle sue vere radici. Così è venuto fuori il piccolo arcano: Concetta è nata e cresciuta in un paesino della provincia di Messina. Prima del matrimonio, viveva tra le pietre calde di quella Sicilia contadina, dove le ragazze sedevano lungo i vicoli a chiacchierare, a intrecciare parole come si fa con l'uncinetto o i ferri. Mi ha parlato delle vendemmie, della pastorizia, di un mondo che oggi appare lontano, eppure così vicino nei suoi ricordi.
Dopo il matrimonio, seguì il marito — anche lui siciliano — al Nord, nel bresciano. E lì ha messo radici, senza però smarrire nulla della sua giovinezza. Ha portato con sé il dialetto, i gesti, i sapori e quella memoria viva che non è nostalgia, ma un vissuto integro, tenace. Quando parlava del suo paese lo faceva col cuore e con gli occhi lucidi. Non era un lamento per ciò che è passato, ma la lucida consapevolezza di un tempo che non ritorna, di una purezza che oggi, dice, non si trova più.
Accanto a lei c'era anche suo figlio. Solo dopo la nascita di sua figlia, mi ha raccontato, è riuscito a fare davvero pace con questa spiaggia. Da adolescente, appena poteva, prendeva il primo treno per il Nord, in fuga. Forse da sé stesso, forse da quel Sud che brucia dentro e a volte fa male. Eppure oggi era lì, in silenzio, come se anche per lui questa riva avesse ritrovato un senso.
Concetta mi ha colpito anche per un altro motivo: porta il nome di mia sorella, e suo marito si chiamava Franco, come me. Ma più di tutto, mi ha riportato alla mente mia madre. Per la sua pacatezza, per i modi aggraziati, per quell'altruismo semplice che sembrava naturale in quelle generazioni. Quanto sapevano donare, senza mai chiedere nulla in cambio.
Con parole semplici, ha spiegato a mia moglie che oggi tutto è cambiato. Sulla spiaggia non si parla più, non ci si conosce, non si condivide. Tutti sono dietro uno schermo. Parlare, incontrarsi, è diventato difficile.
Eppure stasera, sulla riva, grazie a Concetta e a quel tempo che portava dentro, tutto è sembrato per un attimo di nuovo possibile.
C'era l'Architettura
C'era un tempo in cui l'architettura danzava con l'anima, una sinfonia di creatività e passione che permeava ogni progetto. Gli architetti erano artisti, visionari, creatori di mondi. Le loro opere non erano solo edifici, ma manifestazioni tangibili di emozioni.
Ma oggi, il cuore pulsante dell'architettura sembra essere affievolito. Una nebbia burocratica avvolge la professione, stringendo la creatività tra le maglie di norme e regolamenti. Gli architetti, una volta artisti, sono ora diventati prigionieri delle esigenze commerciali e delle regole, una metamorfosi da visionari a burocrati.
Il risultato di questa trasformazione è un paesaggio urbano di grigi anonimi, edifici senza personalità che gridano la loro indifferenza. Dietro a questa deriva si cela un esercito di professionisti spietati, privi di scrupoli e dubbi, costruttori di monoliti senza anima.
Ma c'è speranza, una luce flebile in un cielo offuscato. Per ritrovare l'anima perduta, un cambiamento culturale è essenziale. Gli architetti devono liberare la loro creatività e riscoprire la passione che un tempo li guidava. La società stessa deve svegliarsi, comprendere che gli spazi che abitiamo possono plasmare la nostra esistenza.
In questo nuovo capitolo, gli architetti devono essere liberi di sperimentare, di rompere le catene della conformità e abbracciare la loro visione. Le opere architettoniche devono rispettare l'ambiente, abbracciare i materiali naturali e utilizzare le risorse con saggezza. Gli edifici non devono solo essere scatole funzionali, ma devono elevare la qualità della vita estetica e pratica.
È un appello alla rivoluzione, una richiesta di cambiamento che sussurra nelle pareti di cemento e nelle strade di vetro. I media devono essere un alleato, dando voce a queste creazioni audaci e significative, affinché l'architettura ritrovi il suo posto nel cuore della società.
In questo nuovo mondo, l'architettura non è solo una costruzione di mattoni e malta; è un'arte che ispira, eleva e racconta storie senza parole. È una promessa di spazi che nutrono l'anima, dove ogni angolo riflette la creatività di chi lo ha plasmato. E così, forse, l'architettura riscopre la sua anima, e con essa, il mondo ritrova il suo battito.
Domenica
Portavi il nome della nonna, Domenica. Eri la prima cugina, quella più vicina: nelle gioie e nei dolori. Le nostre case natìe senza confini, senza segreti.
La mia infanzia la tua ombra.
Poi, un malinteso ci ha separati. Il dolore ci ha accecato, ci ha fatto girare le spalle e ha spezzato i nostri cuori.
Il tempo ci ha portato via i nostri cari, che abbiamo pianto separatamente. Il dolore è arrivato oltreoceano, coinvolgendo l'altro ramo della famiglia.
Quando finalmente abbiamo deciso di mettere da parte il rancore, ho scoperto che il destino aveva già tracciato per noi un'ultima, inattesa, separazione.
Scrivo queste poche righe, guardando cadere la pioggia da una finestra che si apre su uno scenario che non ci appartiene. Con lo sguardo seguo il destino delle tante gocce che si rincorrono sul vetro.
Associo al nostro destino quelle gocce che cadono con una tale violenza da dividersi in piccoli rivoli, che vagano brevemente in direzioni opposte. Altre gocce, invece, resistono all'impatto e si rafforzano unendosi tra loro lungo il cammino, fino al limite della finestra.
Passo il palmo della mano sopra gli zigomi e chiudo il taccuino.
Dove avevamo lasciato tutto
Estate, fine anni Novanta. Ero uno studente — ormai fuori corso — di Architettura alla Federico II di Napoli. Mi trovavo a casa, in via San Gregorio Armeno, quando squillò il telefono.
«Pronto?»
«Ciao, sono Leonardo», disse una voce che non sentivo da anni.
«Ciao! Che sorpresa! Da quanto tempo!»
«Ho chiesto il tuo numero a zio Peppe. Anche lui era sorpreso e contento. Tuo padre, poi, è sempre lo stesso: quando gli ho chiesto di te, mi ha risposto con uno dei suoi soliti aforismi.» Sorrisi.
«Sai, Leo, ho davvero voglia di rivederti.»
«Anch'io. Ho bisogno di raccontarti alcune cose... pesanti. Mi sento perso. E in certi momenti hai bisogno di parlare con chi conosce le tue radici.»
«Alle 13:10 parte un treno per Cosenza. Se mi vieni a prendere, ci vediamo in stazione prima delle 18.»
«Perfetto. Ti aspetto.» Preparai una borsa con lo stretto necessario. In treno, aprii Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani.
L'avevo già letto, ma stavolta cercavo di capire meglio la voce narrante — se appartenesse davvero all'autore, o a qualcuno che di lui portava solo l'eco.
Il narratore raccontava di un mondo finito, travolto da leggi e destini imposti, di vite spezzate dalla ferocia del fascismo e dalla deportazione.
Un mondo perduto, che nessuno era riuscito a salvare. Mi chiesi se anche io fossi in viaggio per tentare lo stesso, ma in un modo diverso: non per riscattare una storia collettiva, ma per ritrovare un'amicizia, un frammento di noi che il tempo aveva disperso.
E se fosse ancora possibile cambiare il finale. Quando arrivai, il sole era ancora alto. Giugno ha questo potere: le sue giornate sembrano eterne. Leonardo mi abbracciò forte, ma i suoi occhi erano pesanti.
«Cosa è successo?» chiesi.
«È finita con mia moglie. Penso in modo definitivo.»
«È solo questo? Di salute tutto bene?»
«Sì. Ma è nostra figlia che mi distrugge. È piccola, ha bisogno di entrambi. Non so come reagirà.» In macchina, mi raccontò della casa che avevano costruito insieme, ora diventata una gabbia.
«Ogni mattina è un peso. La cucina ha il suo profumo, il salotto è pieno dei suoi silenzi. Vivo in un museo della mia vita passata.» Leo era sempre stato testardo. Ogni idea, un confronto. Ma ora la sua fragilità mi spingeva a non restare in silenzio.
«I tuoi ti aspettano?» chiese.
«No, sanno che sono con te. Non ho fretta.»
«Aperitivo?»
«Ottima idea.» Ci fermammo in un locale che ci riportò indietro nel tempo. Poi salimmo in montagna, al nostro ristorante di sempre. Durante la cena, mi chiese degli studi.
«Dopo anni sprecati tra amori e sogni, sono quasi arrivato. A breve mi laureo.»
«Fantastico! Hai già pensato a come festeggiare?»
«No. Non voglio farne un evento. Forse ho paura. Finché studio, sono ancora in gioco. Dopo, dovrei essere 'l'architetto'. E non so se voglio esserlo davvero.» Gli raccontai dei nuovi amici, più giovani.
«Una seconda giovinezza. Ci hanno riportati in strada, ci fanno sentire invincibili. È grazie a loro se le moto non sono finite nei garage.» Parlammo anche del suo lavoro alla Citroën. Poi, fumando una sigaretta nel silenzio della notte, dissi:
«Sai, Leo, forse il problema non è quello che è successo, ma come lo guardi. L'amore non è un contratto. È qualcosa che respira. Le persone cambiano, e a volte si perdono. Ma questo non è un fallimento. È solo vita.»
Lui guidava in silenzio, assorbendo le mie parole. Poco dopo, ci trovammo nel largo dove avevamo passato l'infanzia. Sedemmo su una panchina nuova, in un luogo che pareva immutato. I buchi nel muro, dove da ragazzini nascondevamo le sigarette, erano ancora lì.
«Mi chiedi come ricominciare? Forse non devi fuggire o reinventarti. Guarda: ci siamo noi, c'è questo posto. Non siamo cambiati. Siamo tornati a quello che eravamo.»
Ci salutammo con un semplice:
«A domani.»
«Ci vediamo da Domenico, l'ottico», dissi sorridendo. Leonardo mi guardò. E nei suoi occhi, per la prima volta, c'era una luce diversa, non spenta dal dolore. Sapevamo entrambi che l'indomani non sarebbe stato una semplice replica dei giorni passati. Ci eravamo ritrovati, ed era bastato poco per sentirci più forti.
Forse aspettavamo solo questo: tornare a discutere per niente, a mettere le mani nei vecchi motori.
Una complicità muta ci univa, come allora.
Provai un leggero imbarazzo per l'entusiasmo, ma dentro sentivo una nuova lucidità.
Forse ero pronto. Anche a diventare l'architetto. Rimasi sulla panchina ancora qualche minuto, osservando il largo addormentato sotto il cielo stellato.
Una brezza leggera muoveva appena le foglie dei limoni alle mie spalle, portando nell'aria quel profumo secco e dolce che sa di estate e di ritorni. Dalla borsa tirai fuori Il giardino dei Finzi-Contini.
Lo aprii a caso e sfogliai qualche pagina, lasciando che le parole mi scorressero addosso.
Il narratore raccontava di un mondo perduto, di destini che nessuno era riuscito a salvare. Ma quella era una tragedia della Storia.
La nostra, pensai, era solo una pausa della vita. E forse, proprio per questo, non era troppo tardi.
Si poteva ancora riallacciare i fili delle amicizie, ricominciare. La vita, a volte, regala una seconda occasione.
Una seconda giovinezza.
Proprio dove tutto era cominciato.